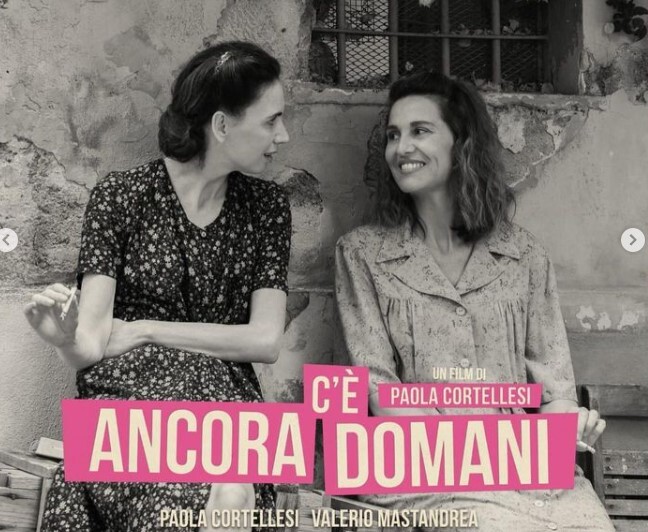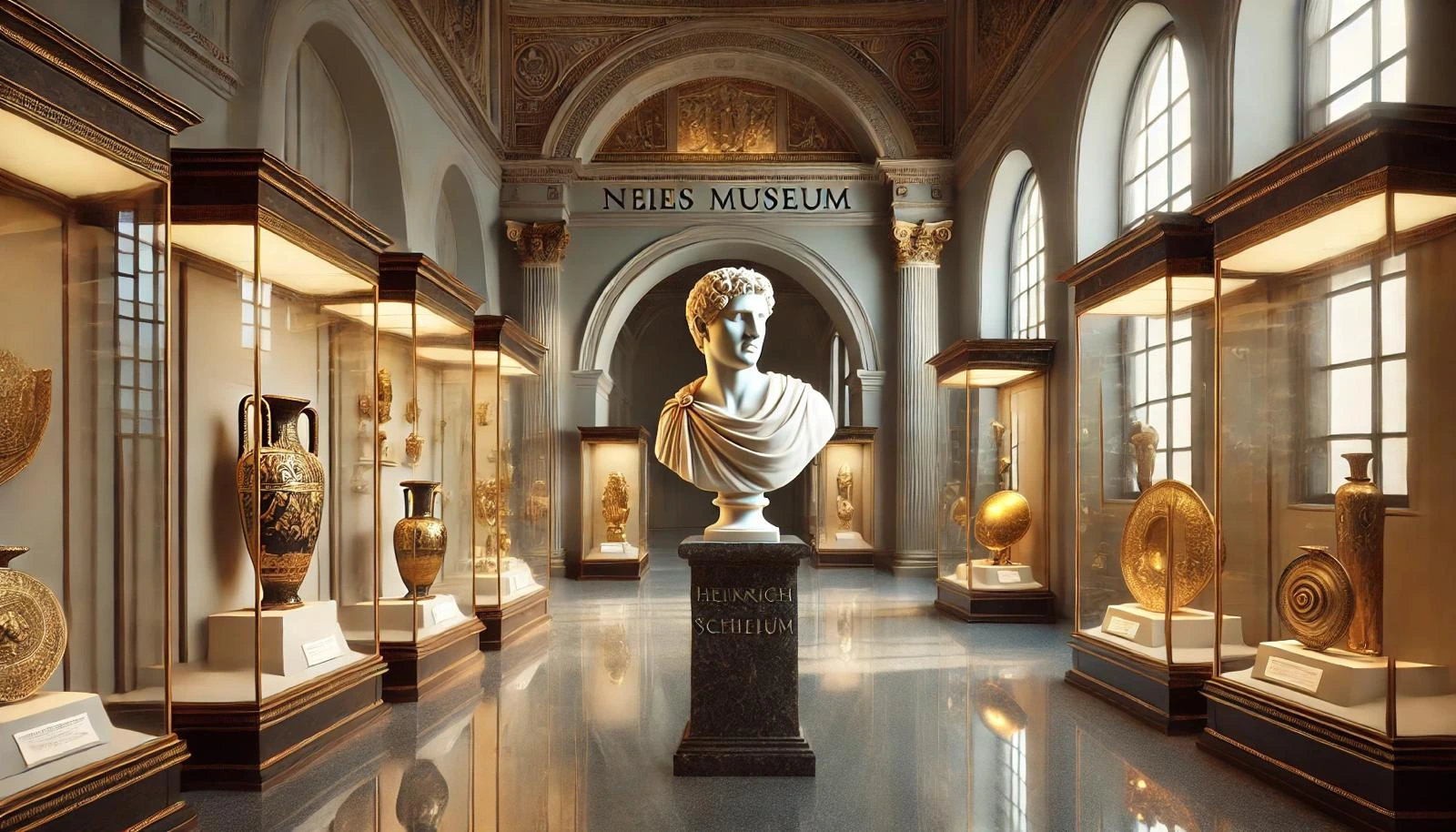Di Lilio Testa
Tutti noi siamo figli della mescolanza di razze. Il miscuglio di razze, credenze, lingue e culture è stato notevole in tutta Europa. C’è stato però un episodio di mescolanza, forse il primo di una certa importanza verificatosi in Europa, che ha segnato il destino del nostro continente e, alla lunga, di buona parte del mondo. Questa prima ibridazione avvenne nella preistoria. Ciò che riusciamo a saperne lo dobbiamo alla linguistica e all’archeologia. Non conosciamo nella stessa misura i due elementi che si mescolarono, anche se siamo eredi di entrambi. La componente indoeuropea, che risultò dominante per ciò che riguarda la lingua e la cultura e sulla quale sono stati improntati infiniti studi e consumati litri e litri di inchiostro. Dell’elemento preindoeuropeo abbiamo conoscenze piuttosto limitate e vaghe. La penisola iberica è uno dei luoghi in cui hanno lasciato più tracce del loro passaggio nella storia. L’Europa preindoeuropea era un mondo complesso, multiforme, variegato, con migliaia di anni di tradizioni, usi e religioni. Tutto un continente culturale che svanì lasciando a malapena un vago ricordo. Marija Gimbutas, brillante archeologa e linguista lituana naturalizzata statunitense, ha definito quel lontano mondo la «Vecchia Europa». Nessuno ha fatto tanto quanto lei per recuperarlo. L’elemento fondamentale che consentì lo sviluppo della Vecchia Europa fu sicuramente l’agricoltura. Questa attività, la cui introduzione è nota come la rivoluzione neolitica, ebbe inizio nel vicino Oriente e subito, verso il 7000 a.C. ma probabilmente anche prima, era ben stabilizzata in almeno tre punti: in Anatolia, in Mesopotamia e nella valle del Nilo. Di qui cominciò a diffondersi sia verso Oriente che verso Occidente. Verso il 5000 a.C. l’agricoltura aveva già una lunga tradizione nella valle del Danubio, nella Grecia continentale, a Creta, nei Balcani e sulla costa orientale dell’Italia. Fu in queste aree che si sviluppò la civiltà della Vecchia Europa che non fu assolutamente uniforme in tutte le regioni. Nei primi anni del V millennio, la civiltà della Vecchia Europa si era cristallizzata in diverse varietà regionali. Vanno menzionate le culture di Cucuteni e Lengyel nella parte settentrionale dell’area, corrispondente a una parte di quella che oggi è l’Europa orientale; di Tisza e Vinca un po’ più a sud; e quella che denominiamo la cultura egea nella Grecia peninsulare e insulare. Cominciarono a formarsi nuclei urbani, alcuni dei quali raggiunsero le dimensioni di piccole città, il che normalmente comporta l’istituzionalizzazione di sistemi di governo locali. Per le loro città, gli antichi abitatori dell’Europa non sceglievano luoghi elevati o di difficile accesso, come più tardi avrebbero fatto gli indoeuropei. Normalmente le città della Vecchia Europa erano situate in luoghi che spiccano per la loro bellezza, l’abbondanza di acqua e il terreno di buona qualità. A volte si stanziavano su piccole alture con una buona vista sul territorio circostante, ma prive di strutture di difesa, perché si trattava di una cultura di gente essenzialmente pacifica. A volte delle modeste palizzate suggeriscono misure di sicurezza contro animali selvaggi o contro forestieri, ma non sistema di difesa seri. Abitavano in case di due o tre stanze, rettangolari, di modeste dimensioni. E all’ingresso di esse c’era una zona scoperta dove cucinavano e lavoravano la pietra per fabbricare i loro strumenti. Benché la Vecchia Europa possedesse un’economia e una struttura tipicamente agricole, i suoi abitanti possedevano animali domestici, principalmente pecore, capre e maiali. Per completare la loro dieta pescavano e cacciavano, forse con l’aiuto di cani. In quest’epoca però utilizzavano il rame, probabilmente già da un bel pezzo, per costruire utensili domestici o rituali e un po’ più tardi l’oro per costruire strumenti e ornamenti. Crearono ceramiche di ottima fattura e policromia. Il commercio dell’oro e del rame si estese per centinaia di chilometri. Probabilmente questi beni preziosi arrivarono fino alle steppe, trasformandosi in uno degli incentivi che alla fine scatenarono l’irruzione degli indoeuropei in questi territori. Nessun indizio archeologico suggerisce che la società della Vecchia Europa conoscesse una divisione in classi sociali/gerarchiche. Non c’erano palazzi più sontuosi delle normali case, né monumenti funerari regali o principeschi. Numerosi invece templi con grandi depositi di oggetti preziosi, il che lascia pensare a una teocrazia o a una monarchia teocratica. In ogni caso, la religione aveva un ruolo centrale in quella società. Gli europei di allora costruivano molti templi e altri luoghi per il culto. Avevano un complicato cerimoniale e vari strumenti rituali. La principale divinità era una divinità al femminile, la Grande Madre apportatrice della vita, assimilata alla terra che genera il frutto del raccolto. La maggioranza dei simboli sono associati alla terra umida, alle acque vivificatrici, agli organi femminili; si basano su elementi ciclici come la luna o il corpo della donna. È abbastanza verosimile che il suo nome, uno dei nomi della Grande Dea della Vecchia Europa, perlomeno in Occidente, fosse Ana o Dana, sopravvissuto poi come epiteto di certe divinità femminili in diverse zone dell’Europa posteriore e già indoeuropeizzate. Questo mondo era concepito come separato dall’aldilà mediante una barriera d’acqua che i morti attraversavano in barca. L’altro mondo era per loro a Occidente e la vita dopo la morte era vista come qualcosa di piacevole, di allegro. Quella fu veramente l’epoca della donna. In sintonia con la concezione divina, la società della Vecchia Europa era matriarcale. La donna occupava un ruolo centrale. L’eredità veniva trasmessa per linea femminile, così come il nome e l’appartenenza a una famiglia. Ma tutto ciò non sembra aver comportato una sottomissione dell’uomo alla donna. La società di quel tempo sembra essere stata molto paritaria dal momento che non c’erano grandi differenze né di classe né di sesso; lo si può evincere dall’usuale fasto delle sepolture. Sicuramente esisteva una divisione delle occupazioni delle funzioni tra uomini e donne. In un siffatto sistema matriarcale la donna sceglieva liberamente il marito o, meglio, i mariti, il concetto di adulterio non esisteva, come non esisteva una punizione per esso. Neanche la verginità aveva valore. Naturalmente è la madre che tiene con sé e educa i figli. Il V millennio rappresenta il momento di massimo splendore della civiltà della Vecchia Europa, ma fu anche il momento in cui ebbe inizio il suo declino. A partire dal 4400 a.C., quella bella cultura diventò l’obiettivo dei pastori barbari delle steppe, che vi giunsero con una serie interminabile di incursioni e di razzie nel corso di quasi due millenni. Ci furono in particolare tre fasi di maggiore intensità. Questo fu per l’Europa un periodo convulso, durante il quale ebbero luogo cambiamenti profondi e traumatici. In questo periodo si veniva plasmando conflittualmente l’identità etnica, religiosa e culturale del continente, e quindi della cultura occidentale. Quello fu probabilmente il momento più critico della formazione dell’Europa. Le civiltà superiori, con la loro ricchezza il loro lusso sfarzoso, hanno sempre attirato i popoli meno civilizzati, diventando oggetto di conquista e, inesorabilmente, di devastazione. Lo stesso schema si è ripetuto innumerevoli volte. In questa occasione la vecchia civiltà europea fu gradualmente penetrata e virtualmente distrutta. Come normale in questi casi, seguì una lunga epoca oscura, durante la quale i vincitori imposero la propria lingua, la propria organizzazione sociale, la propria religione, i propri costumi. Questo, tuttavia, non comportò il genocidio della popolazione preesistente, perché invece le due stirpi finirono col mescolarsi. Ciò che ne scaturì fuori fu la Nuova Europa, quella che essenzialmente ancora vive ai giorni nostri.