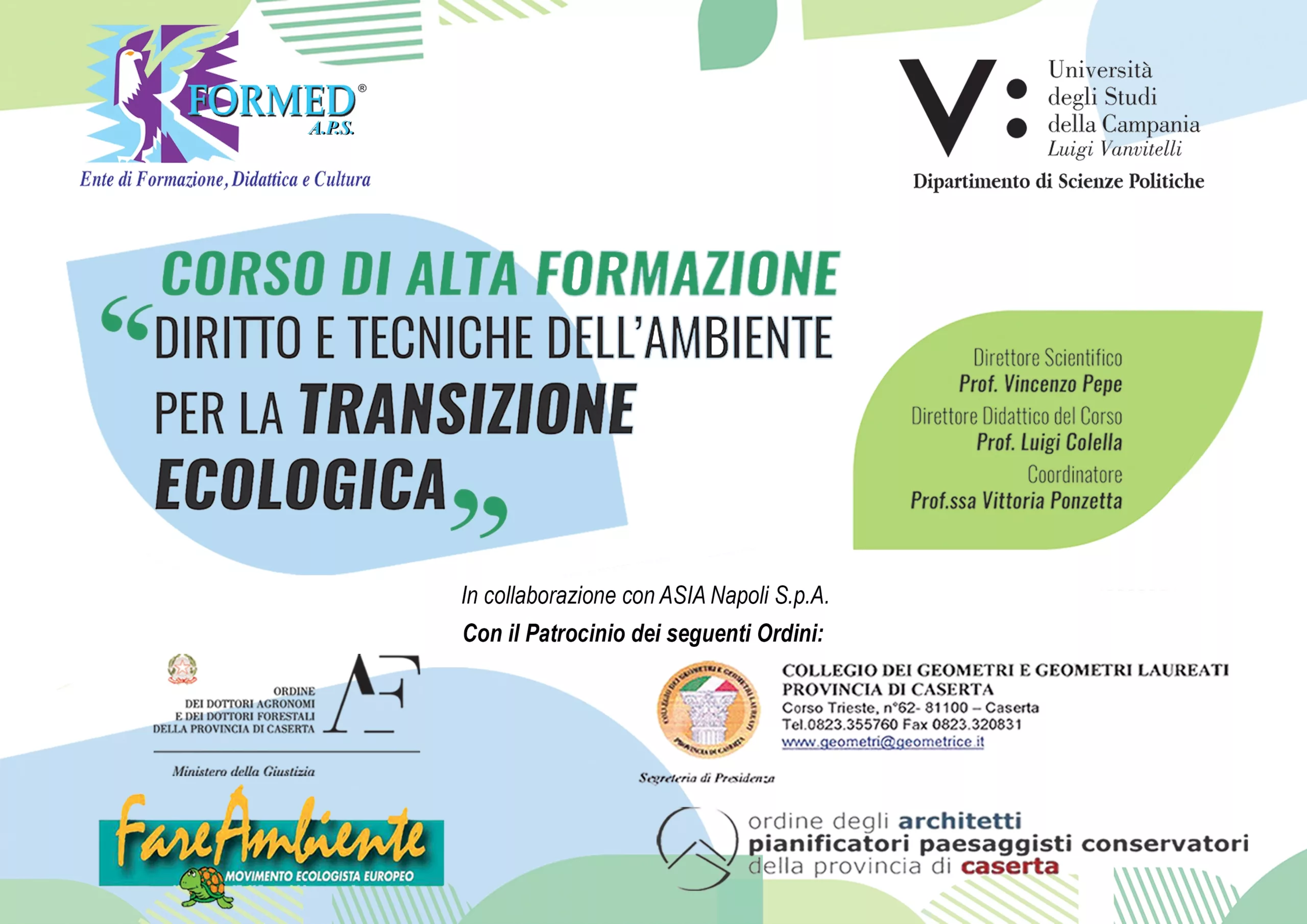Di Enzo Albano
I critici cinematografici, soprattutto quelli italiani, nella loro tradizionale autoreferenzialità che sfocia spesso in un’imbarazzante superficialità di analisi, suggestionati (a loro parziale discolpa va chiesto: come potrebbe essere altrimenti?!) dalla spettacolarità fantasmagorica delle costruzioni narrative di film come “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, “E.T. L’extraterrestre”, la minisaga di Indiana Jones e il grande capolavoro “Schindler’s list”, operano con sicumera una netta distinzione tra uno Spielberg minore ed uno Spielberg più autentico e autoriale ogni qual volta la narrazione si distende su lunghe sequenze dialogate e su ritmi più lenti che caricano le immagini di luce e suoni di ricercato valore simbolico invitando il pubblico ad una visione più mediata e quindi meditata dal punto di vista emotivo. È proprio questo il caso di un bellissimo film, uscito nelle sale italiane nel 1998, “Amistad” che, sviluppando una sceneggiatura di D. Franzoni ispirata al romanzo di Barbara Chase-Riboud “La rivolta della Amistad”, narra le vicende, realmente accadute, di un gruppo di neri africani che, nel 1839, si ribella e uccide l’equipaggio della nave, l’Amistad appunto, che li stava trasportando da Cuba agli Stati Uniti per venderli come schiavi. Gli uomini vengono catturati presso la costa degli Stati uniti e messi in prigione. Il processo che ne segue, per diversi motivi politici ed economici, diventa uno dei più importanti della storia d’America. Il nero Cinquè, capo degli ammutinati africani, forte e intelligente, dignitoso, diventa ben presto un simbolo. Il punto strettamente legale della questione è il fatto che i neri non sono schiavi, ma uomini liberi portati via dal loro paese, la Sierra Leone, secondo quanto emerge dalla difficile ricostruzione della verità. Ma, contemporaneamente, è in pieno e acceso dibattimento la questione nord-sud. Il processo d’appello davanti alla corte suprema diventa politicamente significativo e decisivo perché è inevitabile pensare che, se gli africani saranno assolti, il sud schiavista finirà per ribellarsi. L’arringa decisiva è dell’ex presidente e impareggiabile giurista John Quincy Adams, interpretato da un ispirato e bravissimo Anthony Hopkins. Proprio in questo snodo narrativo, prende vita la scena madre del film in cui l’ambiente, il crescendo musicale in sottofondo, la modulazione attenta delle parole del protagonista hanno fatto storcere il naso a molti tra critici specializzati e spettatori, facendo evocare ancora una volta il sostantivo “retorica” come espressione di esecrabile ipocrisia di una celebrazione opportunista che sfrutta i buoni sentimenti per puntellare un potere il più delle volte ingiusto, come spesso viene percepito, anche dalle nostre parti, quello egemone degli Stati Uniti d’America. In realtà, in questa scena, il presidente John Quincy Adams, sovrapponendosi in un ricercato movimento di macchin ai busti dei presidenti che lo hanno preceduto, cornice simbolica di un’aula di tribunale che è anche storico, pronuncia una vibrante arringa in cui, in un punto cruciale, mette in evidenza la drammatica distanza tra i valori enunciati e dichiarati dalla Dichiarazione d’Indipendenza di pochi decenni prima, fondamento costituzionale che lui impugna in formato cartaceo, e la realtà della condizione di schiavitù dei neri africani, tollerata e sfruttata in gran parte della giovane nazione soprattutto nelle regioni del Sud; a quel punto, dopo avere retoricamente (come un avvocato è chiamato da sempre a fare tecnicamente) chiesto cosa farne di quel documento che ha tra le mani e annunciato che un modesto suggerimento ce l’avrebbe,lo afferra alle due estremità e lo strappa con risolutezza rendendo evidente a tutti quello che è diventato alle condizioni attuali: carta straccia. Ed è proprio lì che avviene la magia del cinema perché proprio allora tutti gli spettatori, a prescindere dalla loro formazione culturale e dalle loro esperienze individuali, intuiscono che le Costituzioni, dispositivi elaborati da uomini per uomini per fissare nella forma definitiva della scrittura ideali e valori da sottrarre per sempre ad autorità divine e all’arbitrio intollerabile degli interpreti terreni di una qualsivoglia volontà ultraterrena, sono un documento che, nella loro forma semplice e lineare, costituiscono il punto fermo verso cui orientare eticamente il nostro comportamento in una tensione costante che tiene unita una comunità al di là della molteplicità di situazioni e di interessi individuali. Così, l’eclatante gesto di denuncia di Adams colloca la Dichiarazione d’Indipendenza americana del 1776 in una sequenza virtuosa di difficile e travagliato processo storico che parte dalle leggi delle XII tavole del V sec. a.C., passa per la Magna Carta del 1215 ed arriva alla nostra Costituzione repubblicana del 1948, e Steven Spielberg ha dimostrato, in pochi esaltanti minuti, che si può raccontare l’epopea di una nazione anche al chiuso di un’aula di tribunale e non necessariamente nei grandi spazi in campo lungo o lunghissimo delle praterie dell’Ovest o in concitate panoramiche di campi di battaglia insanguinati, con buona pace di chi ha liquidato il suo capolavoro “Amistad” come uno Spielberg “minore”. A tal proposito, mi sovviene in mente che, un anno fa circa, conversando amabilmente di cinema con un famoso critico cinematografico, che potrei tranquillamente considerare una mosca bianca per le sue diverse posizioni lontane dal mainstream, mi ha confessato che, chiamato anche lui ad esprimere in maniera estremamente sintetica per stringenti motivi editoriali il suo giudizio sulle opere cinematografiche sottoposte alla sua attenzione, per scelta personale non si esprimeva mai al di sotto della sufficienza perché era convinto che, al di là della realizzazione più o meno riuscita delle intenzioni narrative e figurative, dietro un film c’è il lavoro motivato di tante professionalità, ovvero di tanti esseri umani che hanno impegnato le loro preziose competenze pensando sempre di collaborare a qualcosa di importante e di unico, all’espressione di un’idea valida da trasformare in un racconto, ad un sogno da trasformare in realtà. E, a questo punto, non posso fare a meno di pensare che tutto ciò, se vogliamo ancora parlare di democrazia, sia autenticamente e preziosamente… costituzionale!