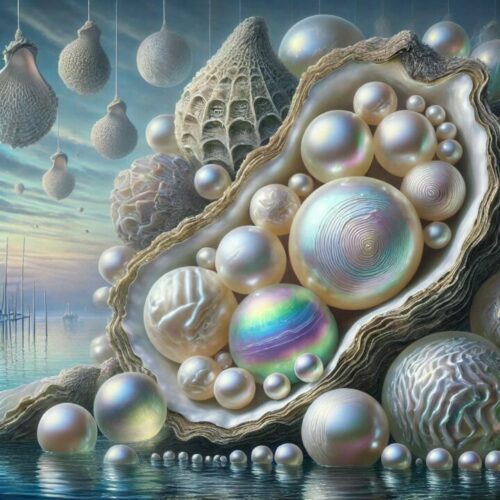GEMMOLOGIA ANTICA vi svelo che:
Parte prima
L’archeogemmologia: ambiti e applicazioni
L’archeogemmologia studia i materiali usati come gemme o ornamenti nell’antichità, rinvenuti negli scavi archeologici. Analizza la loro provenienza geologico-geografica in relazione ai giacimenti sfruttati anticamente, il loro commercio e le tecniche di lavorazione glittica (incisioni e intagli), ma anche i significati magici e le proprietà terapeutiche attribuite ai materiali stessi. Si occupa dei processi di alterazione che le gemme subiscono a causa dell’uso o dell’interramento ipogeo in tombe o paleosuoli archeologici, talvolta per millenni.
È una disciplina utile per individuare falsificazioni gemmologiche e glittiche, antiche e moderne, scartando materiali che non venivano usati storicamente (perché sconosciuti o sintetici) o riabilitando manufatti autentici esclusi a causa di analisi frettolose.
L’archeogemmologia si colloca tra l’archeologia tradizionale e le scienze della terra (mineralogia, petrografia, geochimica) e fornisce informazioni cronologiche, stratigrafiche e paleoclimatiche. È inoltre fondamentale per individuare tecniche di invecchiamento artificiale, distinguendo manufatti autentici da falsi.
Il termine “gemme” nell’antichità
Con “gemme” si intendono pietre, minerali, fossili e materiali organici (come ossa, avorio, corallo, ambra e conchiglie), che nell’antichità non venivano apprezzati tanto per le loro caratteristiche chimico-fisiche, quanto per la convinzione, radicata nella superstizione, che possedessero virtù terapeutiche e proprietà magiche, come la capacità di scacciare malocchi o demoni.
L’uomo, fin dalla preistoria, ha utilizzato materiali litici, dalla selce e ossidiana per strumenti e armi, ai monumenti megalitici, piramidi, ziggurat e templi. Le gemme erano considerate simboli di sacralità, incorruttibilità ed eternità. Erano legate ai quattro elementi primordiali (fuoco, terra, aria, acqua), con una visione che attribuiva a queste pietre un’origine divina: si pensava che alcune fossero cadute dal cielo (meteoriti), come le “pietre del cielo”, o che fossero state generate dall’influenza divina, come le “pietre fulmine” (selce usata per armi), le ceraunie (sfere di selce) e la “polvere di luna” (gocce vitree di impatti meteoritici). La geometria dei cristalli, la trasparenza dell’ambra, lo splendore metallico e la luminescenza delle perle conferivano loro un’aura di sacralità e mistero.
Valore e simbolismo delle gemme
Le gemme grezze, i pendenti e gli intagli erano preziosi per i loro presunti poteri più che per la loro bellezza o rarità. Solo in tempi più recenti il valore delle gemme è stato regolato dai parametri della gemmologia moderna (4C: colore, purezza, caratura, taglio). Nelle civiltà mesopotamiche (Sumeri, Assiri, Babilonesi), fin dal IV millennio a.C., le pietre erano strettamente legate ai cicli cosmici e astrologici. Amuleti come i cilindri mesopotamici incisi, inizialmente talismani scaramantici, divennero in seguito sigilli.
Nella tradizione egizia, ogni giorno del mese era associato a una pietra, e così avveniva per i segni zodiacali, una tradizione poi ripresa dagli Ebrei, come dimostra il Pettorale del Gran Sacerdote Aronne, con 12 gemme incise, simbolo delle 12 tribù di Israele.
Trattati sulle pietre nell’antichità
Il primo trattato di mineralogia, Intorno alle pietre (315 a.C.) di Teofrasto, divideva le pietre in “maschi” e “femmine” e attribuiva loro proprietà terapeutiche e magiche, come lo smeraldo, che “giova agli occhi”. Successivamente, i Lapidarii medievali si concentrarono sulle proprietà medicamentose: lo zaffiro (probabilmente lapislazzuli) era ritenuto utile contro i morsi di serpenti velenosi, mentre la pietra di luna contrastava l’epilessia. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia (I sec. d.C.), documentò numerose pietre, ma con scetticismo, attribuendo le loro proprietà a invenzioni di maghi e ciarlatani.
Epoca alessandrina e Medioevo
In epoca alessandrina (II-IV sec. d.C.), l’alchimia influenzò la letteratura sulle pietre, come nel trattato Cyranidi, attribuito a Ermete Trismegisto. Ogni capitolo era dedicato a una pietra, un’erba, un animale o un pesce, simboli dei quattro elementi primordiali. Nel Medioevo, Lapidarii ripresero queste tradizioni, mescolando informazioni reali e materiali inventati. Esempi di pietre leggendarie includono:
- Eliotropo: calcedonio verde con punteggiature rosse, ritenuto capace di trasformare la luce solare in riflessi sanguigni.
- Bufonite: dente fossile di pesce, ritenuto talismano contro l’idropisia.
- Bezoari: calcoli biliari di animali, usati contro i
- Glossopetre: denti fossili di squalo, creduti fulmini
Anche vescovi come Epifanio e Isidoro di Siviglia tentarono di catalogare le gemme, associandole ai quattro elementi, ma con risultati spesso confusi. Nel De Mineralibus (1260), Alberto Magno cercò un approccio più scientifico, pur mantenendo influenze medievali.
Geologia delle gemme
Le rocce, costituite da minerali, possono formarsi attraverso processi magmatici, sedimentari o idrotermali. Il magma, raffreddandosi, consente la cristallizzazione di minerali, formando giacimenti o cavità in cui si accumulano materiali come quarzo e calcedonio. Le sorgenti termali e le acque minerali contribuiscono ulteriormente alla formazione di nuovi minerali.
Taglio e lavorazione delle gemme
Le pietre preziose sono apprezzate per lucentezza, trasparenza e rarità. Anticamente venivano mantenute al naturale, ma con il tempo furono lucidate e tagliate per valorizzarne colore e brillantezza. L’arte del taglio, sviluppata in India ed Egitto, raggiunse la perfezione con il taglio a brillante (XVII sec.), che esalta i riflessi interni. Le pietre opache vengono invece lavorate a cabochon, con superfici arrotondate.
 ricerca curata dal Gemmologo Dr. Fabio Pivari
ricerca curata dal Gemmologo Dr. Fabio Pivari