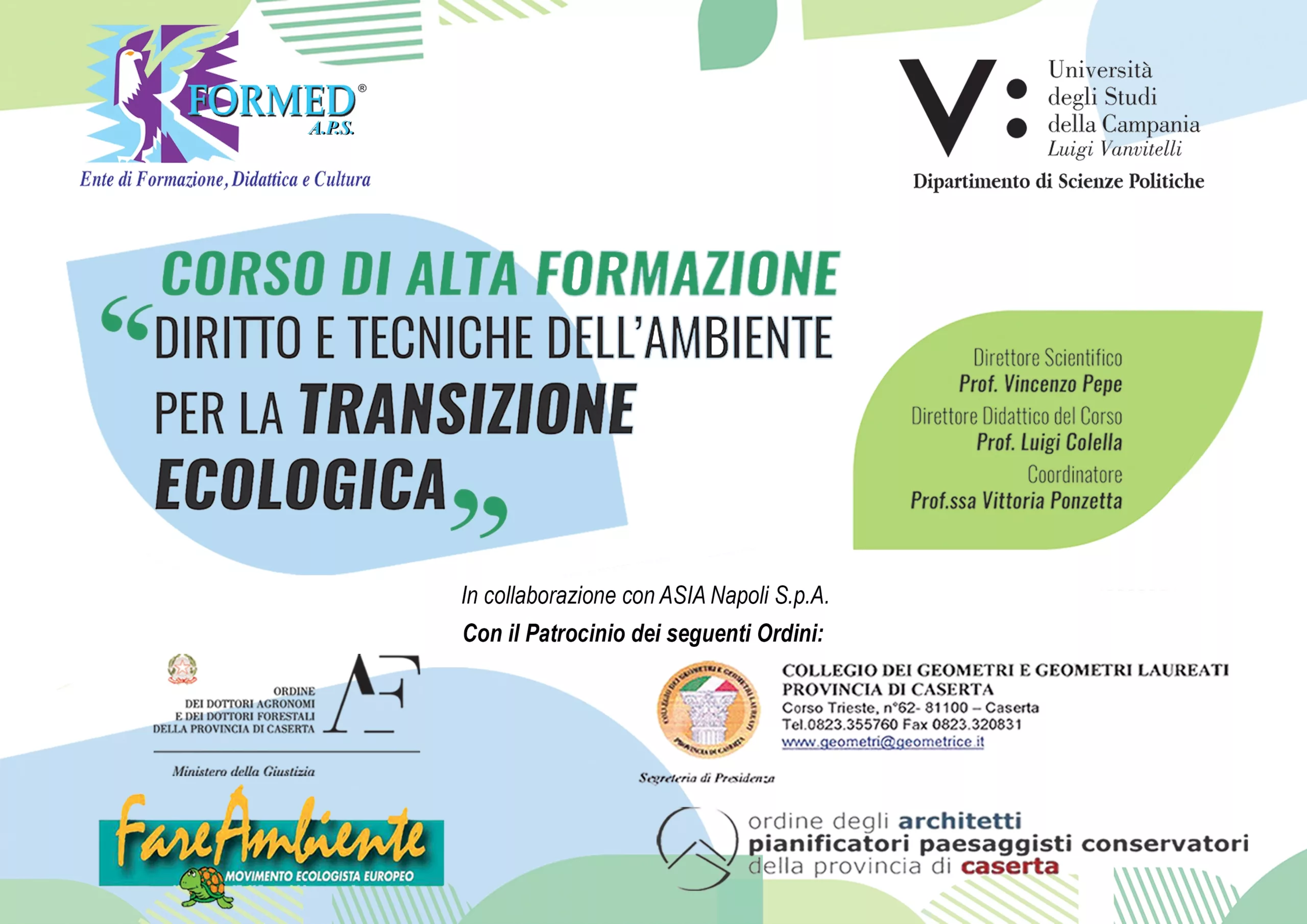Di Enzo Albano
A volte, da insegnante contemporaneo, tra un incontro on-line con gli esperti per l’orientamento (hanno chiamato il progetto “Orizzonti”, quasi a voler rimarcare che hanno deciso loro dove portare la barca, senza consultare i passeggeri) e un’uscita didattica, più o meno stimolante, tra una convocazione dei genitori per motivi disciplinari (le regole son regole, per tutti…) e un Collegio Docenti per ratificare con approvazione quasi unanime la ripartizione, accuratamente elaborata dallo staff amministrativo, del diluvio di fondi da spendere per il PNRR (ripresa e resilienza, per tirarci tutti un po’ su) mi piace prendere un attimo di pausa per fare un po’ il punto della situazione e cercare di capire dove stiamo andando. Ogni tanto, mi allontano dal registro elettronico, dai resoconti puntuali delle attività didattiche ed inizio a pensare. Ebbene sì, ogni tanto, da insegnante ed essere umano, mi piace pensare. E allora penso che, se la prima testimonianza importante di attività letteraria, affidata all’oralità, è il canto epico, narrazione articolata e complessa di eroi e divinità in cui gli aedi, cantori professionisti, combinavano parole e musica per favorire negli ascoltatori la creazione di immagini; se l’apporto più consistente al repertorio lessicale di una lingua nazionale l’hanno dato i poeti “visionari” nell’atto creativo che plasma parole e modella strutture sintattiche per produrre nell’anima del lettore immagini non riscontrabili facilmente nell’esperienza quotidiana ma cariche di significato e quindi possibili come ha fatto Dante, nella sua “Commedia” per far vedere a tutti le conseguenze eterne delle scelte morali di una vita nei tre regni oltremondani; se, tra i testi d’uso non letterari più conosciuti, una sceneggiatura, in cui un racconto è strutturato in scene da realizzare con l’apporto concreto operativo di tutti (regista, operatore di ripresa, scenografi, costumisti, truccatori, parrucchieri ed altre maestranze) per la realizzazione di immagini in movimento da far vedere concretamente agli spettatori di un film, allora sì che possiamo affermare con convinzione che il cinema, con il suo linguaggio specifico, così curato tecnicamente e così dissimulato nella fluidità narrativa, è il punto di approdo definitivo di una tensione creativa che fonda le caratteristiche peculiari del genere umano all’interno dell’universo, più che sullo sviluppo di un linguaggio articolato, sulla capacità innata di raccontare storie e dobbiamo constatare, ahimè, ancora una volta, che l’istituzione scolastica è arrivata un po’ troppo tardi, come al solito, a comprendere che, nella formazione del cittadino, non si può prescindere da un’educazione al linguaggio cinematografico perché un’immagine in movimento, una scena ben realizzata, può contenere più verità sulla condizione umana di quanta ne contenga un saggio filosofico o un capitolo di un romanzo, pur di pregevole fattura. Avviene allora che, accanto alle grosse produzioni, soprattutto statunitensi (l’egemonia industriale è ancora ben salda nelle loro mani), che, aiutate dalle strabilianti risorse della tecnologia digitale, rinnovano la tradizione della visionarietà con la creazione e lo sviluppo di mondi ed universi paralleli (vedi le saghe Marvel in sala e sulle piattaforme con i supereroi che hanno monopolizzato da tempo le preferenze carnevalesche dei più piccoli) caricando l’epicità della sempiterna sfida tra bene e male con le emozioni strabilianti della spettacolarità, continua ad essere realizzato (e mi piace considerarla una piccola sacca di resistenza) un cinema “umanistico” che affida le considerazioni e gli spunti di riflessione sulle difficoltà dell’esistenza umana a risorse meno costose ma non meno efficaci: la luce, la recitazione degli attori, il commento musicale, la disposizione di esseri umani ed oggetti in un ambiente, più propriamente nell’inquadratura. Appoggiato ad una finestra del corridoio al terzo piano, schermata da sbarre di metallo (misura opportuna: i ragazzi, oggigiorno, sono imprevedibili…) che mi ricordano un carcere, mi viene in mente all’improvviso un bel film “umanistico” di qualche anno fa: “L’aria salata” (2006), primo lungometraggio di Alessandro Angelini, sensibile regista proveniente dal documentario, di cui abbiamo visto in televisione qualche giorno fa l’interessante biopic “Califano”. La storia sostanzialmente è questa. Fabio, un ragazzo sensibile e motivato, lavora come educatore nel carcere romano di Rebibbia dove ha il compito di rieducare i detenuti e aiutarli nel loro difficile l’inserimento in società. In prigione, viene casualmente in contatto con il padre, il detenuto Sparti, che lo ha abbandonato quando era ancora un bambino e che si trova dietro le sbarre da vent’anni accusato di omicidio. Con il passare del tempo, nasce tra padre e figlio un rapporto segreto a tutti e molto sofferto. Un giorno, come da programma, il ragazzo si incontra con il Direttore, la guardia carceraria Lodi e l’avvocato per discutere dell’elenco con le domande di tutti i carcerati che, tramite lui, hanno fatto richiesta di un giorno di permesso. Dopo l’analisi consuetudinaria delle diverse situazioni di tutti i detenuti richiedenti, quando finalmente sembra che abbiano terminato, Fabio afferma con aria preoccupata che non hanno ancora finito perché c’è proprio lui, il detenuto Sparti. L’agente Lodi, scusandosi, chiede retoricamente cosa debbano ancora dire di più sul detenuto in questione e sottolinea che è vero che sono uno stato democratico ma dubita che siano anche uno stato stupido se poi spendono soldi e tempo per uno come lui imitando Sparti e le sue crisi epilettiche per mettere cinicamente in dubbio la sua malattia. Fabio, deciso più che mai, sostiene che la sua relazione di educatore è positiva perché con lui il detenuto parla e ha fatto dei notevoli progressi. Allora, l’agente, meravigliato dell’atteggiamento dell’educatore, ricorda che lui di solito non si lascia fregare come un cretino e ribadisce sicuro di sé che Sparti fa finta consigliandogli contestualmente di fare attenzione a non sbagliare, Di fronte alle perplessità, condivise anche dal Direttore e dall’avvocato con incertezze e tentennamenti, sulle possibilità di riscatto del detenuto, Fabio, figlio in incognito, scoraggiato e spazientito, dice provocatoriamente che ha cambiato idea e propone di tenere lì il detenuto in questione per altri vent’anni in modo tale che il poliziotto possa continuare a farlo cadere dal letto (rapporto ufficiale per coprire le usuali punizioni corporali abusive dei detenuti) e il direttore possa continuare a fare finta di curare lui e gli altri detenuti aspettando che si ammazzi da solo e risolva il problema a tutti. Dopo lo sfogo, ribadisce che è la legge a stabilire che il richiedente può uscire in permesso. La guardia gli assicura che, appena uscito, Sparti lo fregherà. Fabio risponde deciso che quella è una possibilità ma aggiunge che è anche possibile il contrario. Con questo prezioso dubbio, la scena si conclude ed io non posso fare a meno di notare che, nella vivace discussione, in quella piccola stanza arredata spartanamente con due scaffali piene di cartelle portadocumenti e un tavolo pieno di carte, frammenti volanti di vite spezzate, era assente prorpio il personaggio principale: il detenuto Sparti. Ho letto da qualche parte che la condizione dei detenuti nelle carceri è uno dei misuratori più efficaci della tenuta democratica di un paese ed io, a ripensare quella scena, ogni volta, non mi sento tranquillo…Suona la campanella, è ora di smettere di pensare: il mondo mi vuole educatore, efficiente e produttivo. Non mi perdo d’animo: entro in classe, appoggio la borsa sulla cattedra, mi giro verso i ragazzi e dico: ”Ragazzi, accendete la LIM! Oggi vediamo un bel film: ”L’aria salata”. Poi, ne dobbiamo parlare un bel po’…”. Con buona pace del programma o programmazione didattico-educativa o piano di lavoro che dir si voglia: cambia il nome ma il precipizio è lo stesso. Ho smesso di pensare: passo all’azione e mi gioco un’altra possibilità. Silenzio in sala, pardon, in aula: facciamo finalmente lezione!